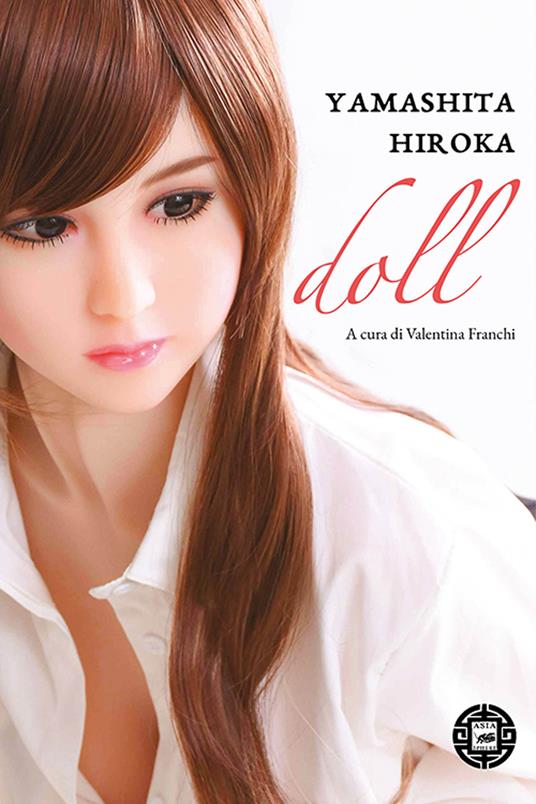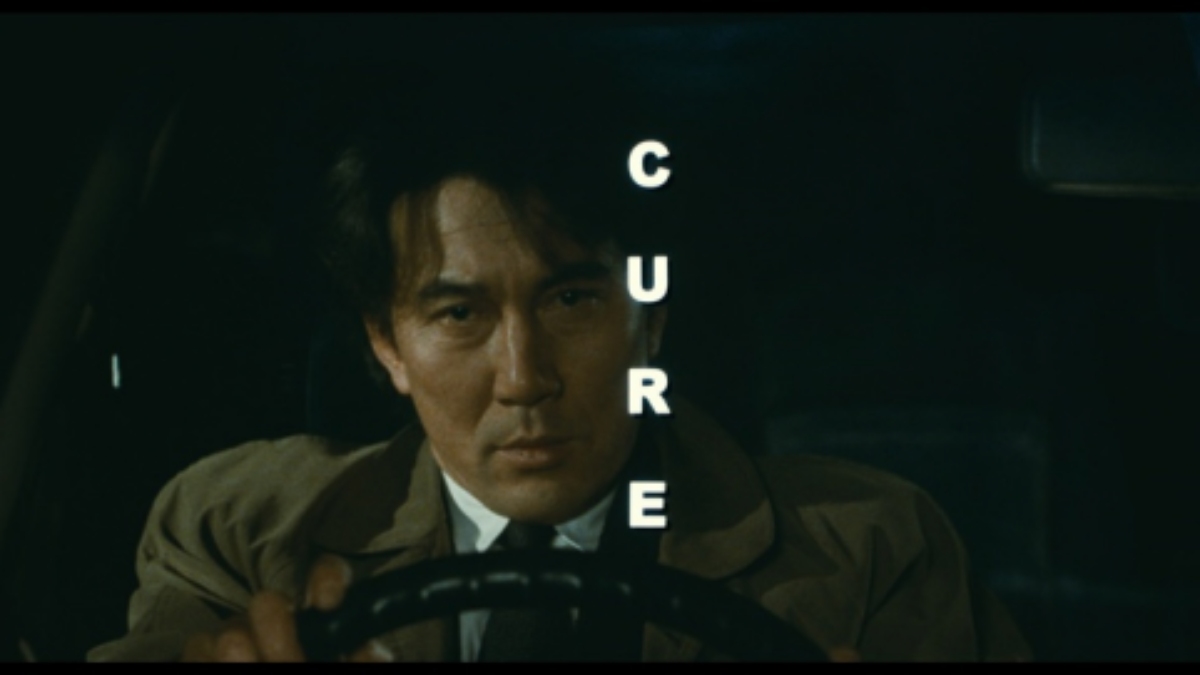In principio era il furoshiki, il tradizionale foulard giapponese. Più o meno prezioso nel tessuto o nelle decorazioni, era utilizzato per avvolgere oggetti e scatole. Il suo uso risale all’epoca Nara (710-784 d.C.), quando era destinato a proteggere oggetti di valore appartenenti ai membri della famiglia imperiale.
Nella successiva brillante e raffinata epoca Heian (794-1185) il suo impiego si allarga al trasporto e alla conservazione dei ricercati kimono nei cui numerosi strati si drappeggiavano i nobili della corte. Per poi approdare con l’emergere della vivace e gaudente borghesia metropolitana agli inizi del 1600 alla più popolare atmosfera dei bagni pubblici.

L’origine del nome
Proprio in questo contesto metropolitano nasce il termine furoshiki, da furo [bagno] e shiki/shiku [stendere]. Precursore fra le altre cose del moderno asciugamano rettangolare che si usa portare nel bagno pubblico una volta denudatisi, veniva infatti steso a terra per sedersi. E per finire, sempre in epoca Edo (1603-1868), divenuto ormai oggetto d’uso comune, inizia una nuova vita come accessorio irrinunciabile per la working class, che lo utilizzava per il trasporto delle merci e mercanzie più svariate.
Dall’oblio a un nuovo valore
Sopravvissuto allo scompiglio portato alla fine dell’Ottocento dalla modernizzazione/occidentalizzazione, il furoshiki conosce una fase di oblio nel dopoguerra: sono gli anni del boom della cultura americana, nei quali si assiste al dilagare del ‘sogno giapponese’, modellato sull’american dream proposto dalle pellicole hollywoodiane che inondano le sale cinematografiche e le riviste patinate. Gli anni nei quali il Giappone scopre il latte, di cui diventa presto uno dei più forti consumatori, e le buste di plastica, che soppiantano nell’uso quotidiano il tradizionale rettangolo di tessuto.
La rivincita arriverà con lo scoppio della bolla economica e la successiva lunga fase di recessione, che porta in primo piano nuovi temi, quali l’inquinamento ambientale. Il ritorno del furoshiki è frutto della ridestata coscienza ecologista del paese. Compatto quando ripiegato e riutilizzabile all’infinito, diventa infatti presto il simbolo dell’imballaggio eco-friendly. Come il mottainai furoshiki ideato e lanciato nel 2006 dal Ministro dell’Ambiente Yuriko Koike, di fibra derivata dal riciclaggio delle bottiglie in PET.
Il furoshiki moderno
Oggi i furoshiki possono essere realizzati in una pressoché infinita varietà di fantasie, dimensioni e materiali, dalla seta al cotone alle fibre sintetiche, a seconda dell’uso, funzionale o decorativo. E la loro vitalità inesauribile all’interno della cultura materiale tradizionale è il segno forse più tangibile ed evidente dell’importanza che il packaging riveste in Giappone.
La sua storia suggerisce che i giapponesi amano avvolgere gli oggetti, dalle bottiglie di sake ai bentō – la versione nipponica del pranzo al sacco – ai kimono di seta. E, in base a quella che Joy Hendry ha definito con un’espressione particolarmente felice ‘wrapping culture’, il gesto implica che tanto all’oggetto quanto al contenitore vengano attribuiti un significato e un valore speciali. Soprattutto – come è ovvio – nel momento in cui si tratta di offrire qualcosa in dono. Infatti in Giappone è considerato scortese e irrispettoso regalare un qualsivoglia oggetto che non sia debitamente confezionato; compreso il denaro per il quale esistono apposite buste sottili ed eleganti variamente decorate per adattarsi di volta in volta all’occasione.


L’estetica del packaging
Il gusto per il packaging dunque ha in Giappone radici profonde, nelle quali si intrecciano strettamente valori d’uso ed estetica. L’odierno quotidiano rigurgita di beni di lusso o di consumo che arrivano ai fruitori nipponici in un curato imballaggio. Afferente da un lato al complesso universo del design, l’imballaggio è immerso dall’altro nel ciclo manifattura-distribuzione-commercializzazione-uso-smaltimento, e assolve una o più funzioni sociali.
Infatti, nella homepage del sito della JPDA (Japan Package Design Association), si legge: [l’associazione]è stata fondata nel 1960, nella speranza che il package design potesse ottenere il pubblico riconoscimento. […] si dedica alle proprie attività con l’obiettivo di dare un contributo alla società, realizzando progetti accattivanti e creando opportunità di connessione fra persone, persone e aziende, persone e beni. Certo, quando riceviamo un regalo oppure compriamo uno snack o una bibita nel convenience store più vicino, nella maggior parte dei casi l’involucro è solo un ostacolo che ci separa dall’agognato contenuto. Qualcosa da strappare frettolosamente, e nemmeno uno dei concetti espressi sopra ci attraversa la mente. Eppure anche in situazioni come queste può capitarci di imbatterci in esempi di packagingdesign che riescono a catturare la nostra attenzione al di là della fame, della sete o della curiosità.
Solo apparenza o anche praticità?
Come la gift box per le mele di Tsugaru, nella prefettura di Aomori, bronzo ai Pentawards 2012, il più importante concorso per il packaging design del mondo, che nel design ricorda il furoshiki e, per traslato, i valori tradizionali, primo fra tutti quello dell’ospitalità. La frutta infatti – costosissima per i nostri standard – in Giappone viene regalata spesso quando si viene invitati a casa di amici, parenti, conoscenti.

Argento nello stesso anno invece per la lattina di una bibita molto popolare, Gokuri, succo e polpa di frutta. Un design lineare e asciutto, accattivante nella semplicità della forma. Nel 2013 per altro la versione alla banana vince il bronzo. Le bevande in effetti hanno ispirato negli ultimi anni diversi designer, che – come nel caso della gift box vista sopra – spesso traggono spunto dall’iconografia o dalla cultura materiale della tradizione. Un esempio per tutti il package del tè Iyemon, che ricorda le sottili canne di bambù che caratterizzano tanta parte del paesaggio giapponese: delicate linee verticali e colori sfumati che richiamano l’estetica delle ceramiche utilizzate nel cha no yu, la cerimonia del tè, divenuta in anni recenti uno dei simboli più global-popolari del Giappone.


Insomma, il packagingdesign giapponese sembra sgorgare da una potente energia immaginativa, e gli involucri o imballaggi o confezioni creati per essere non soltanto dei contenitori, ma oggetti da godere per se stessi, attraverso il tatto, la vista, l’olfatto.
(Paola Scrolavezza, da Art e dossier n. 326, novembre 2015)