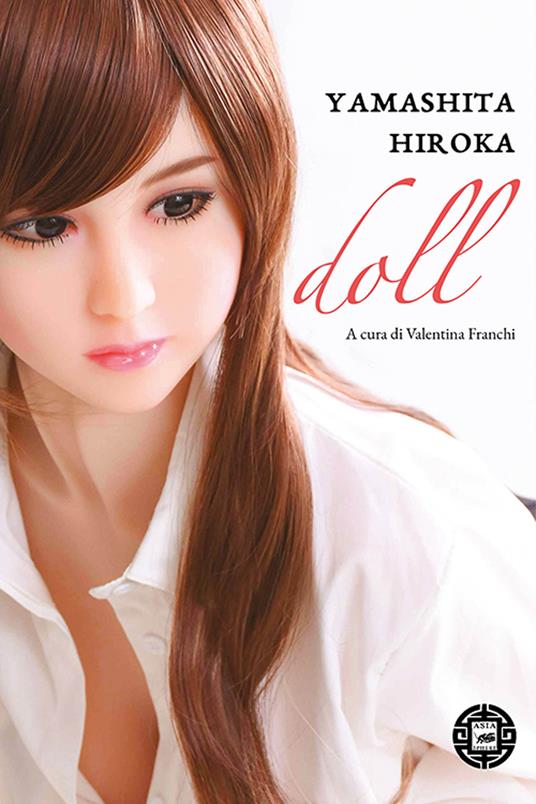"Milano per due giorni capitale del sakè". Dovrebbe incominciare così un articolo che si rispetti sul Festival del Sakè organizzato il 20 e 21 settembre dall'associazione La Via del Sakè nei chiostri austeri, mondani e modaioli dell'Umanitaria, in pieno centro.

E si dovrebbero menzionare per bene patrocinatori e consolati. Tuttavia questo non è un articolo comme il faut, ma solo il resoconto dell'esperienza di un vostro amico di tastiera tra una degustazione e l'altra, una chiacchiera e la successiva, e molte sensazioni parallele e incrociate. Non me ne vogliano pertanto produttori, associazioni, sponsor e diplomatici, ma fo di testa mia così come ho fatto di palato mio.
Si comincia subito con un dubbio assillante, una di quelle cose per le quali temi di giocarti faccia e reputazione su un sito navigato da esperti di Giappone, iaponismi e nipponerie quali voi certamente siete: sono sicuro che mi passerete i neologismi, ma l'accento, quel diabolico accento, sul sakè va messo o non ce n'è? Decido di ispirarmi pedissequamente ai cento pieghevoli che ho asportato dai banchi del festival e che l'accento non lo mettono, ma poi ecco il centunesimo, maledetto, che invece, come per ischerzo, eccolo lì, quel baffo d'inchiostro sulla "e": sakè. Che faccio? La via pragmatica è la meno faticosa: lascio fare al correttore che l'accento invece lo appone senza esitazione, vi toccherà pertanto prenderlo così com'è.
Vi dico subito che, nonostante io abbia fama tra gli estimatori – o forse solo i beneducati – di sapiente gourmand e, tra i detrattori più sfacciati – ma forse più onesti – di onnivoro mangione e onnipote beone, di sakè sapevo e so ben poco, anche se ora, dopo il Festival, ne so un po' di più. Tuttavia non sono andato per sapere, ma per bere e scoprire, giacché più di quelli del cervello mi interessano i palpiti della gola.
Immaginatevi una decina di tende sparse qua e là per il bel cortile interno, con parecchia gente, molti giovani, tutti assai interessati al misterioso liquore che liquore non è, bensì vino, vino di riso. E che vino! Dotato dell'apposito ochoko, la piccola chicchera senza manico con cui si degusta, mi sono avvicinato alle bottiglie e ai loro presentatori. Parto proprio dall'ochoko, un bell'oggetto, semplice, che ti obbliga a causa delle piccole dimensioni a sorseggiare più volte, lentamente. Tuttavia credo che un bicchiere sarebbe assai meglio, un bicchiere studiato apposta da qualche enovetreria, un bicchiere piccolo, sottile, trasparente, che faccia apprezzare in pieno il non colore del sakè, la sua limpidezza o – per il non filtrato – la sua diversa opacità che arriva a farlo assomigliare in taluni casi a un siero di latte, bianco e diafano. Magari con un piccolo stelo che allontani l'odore della mano dal naso, affinché il vino di riso possa esprimere la sua varietà di bouquet e di contrasti sorprendenti in modo tale da essere accolti dalle narici senza essere vittima di afrori personalissimi, lavande e sandali di questo o quel sapone e raccapriccianti antologie di disturbi olfattivi.
I produttori presenti erano – come ci si aspetterebbe – quasi tutti giapponesi, con qualche sorpresa eccezionale: un piccolo produttore norvegese, un ragazzone colto e letterato che fa tre tipi di sakè, ma li fa con amore e dedizione e ottiene un prodotto che ha fatto emettere gridolini di giubilo a qualche ragazza giapponese presente. L'azienda si chiama Nøgne, importa riso già preparato dal Giappone e lo fa fermentare tra i fiordi. Mi preme segnalare uno straordinario Yamahai Motoshibori con 19% di alcool, strutturato, vanigliato, perfetto con formaggi stagionati o erborinati grassi. Leggermente acido sul finire, lo berrei bene anche con un rombo o un salmone alla crema o i tagliolini storici del mitico Angelone Paracucchi (anni '70), con crema di latte, scalogno e salmone. Un piatto rotondo, pieno, grasso, voluttuoso che ha bisogno di essere abbracciato da un vino potente e gentile come il nostro di Nøgne, già vincitore di un premio a Londra nel 2012.
Ho già consigliato un'etichetta senza aver detto tuttavia che cosa sia il sakè: cerco di rimediare. Non si tratta di un distillato, non è cioè una grappa o un brandy di riso: è un vino ottenuto dalla fermentazione del riso cui viene aggiunto un microorganismo chiamato koji e, naturalmente, acqua. Il chicco di riso deve essere pulito, la superficie viene rimossa con una tecnica molto sofisticata riducendone il volume anche del 65%. È dal cuore del chicco che si ottiene il migliore risultato. La fermentazione, come per il vino da grappolo, può avvenire in acciaio o legno, può essere completamente naturale o rinforzata con un po' di alcool che porterà spesso a ottenere un prodotto più secco.
Il sakè è prodotto in tutto il Giappone dallo Hokkaido a Okinawa, sviluppando sentori, aromi e note completamente diverse a secondo del luogo di produzione e della stagione. Una volta imbottigliato dura normalmente un paio d'anni, tranne che per i vini invecchiati che arrivano anche ai 40 anni di cantina, evolvendo in modo inimmaginabile, non tanto diversamente da un porto: dapprima una leggerezza aromatica, poi uno strutturarsi deciso, infine una eleganza e una morbidezza di rara sensualità. La temperatura di servizio è quella di un vino rosso, evitate come la peste i freddi eccessivi, che cancellano le sfumature, e la somministrazione a caldo – magari ottenuta con un drammatico microonde – che tende a esaltare solo le note alcoliche e a inibire o uccidere tutto il resto.
I dettagli "tecnici" sono certamente importanti, ma distraggono il degustatore neofita e lo privano dell'esperienza del piacere che deve invece essere intensa, stordente e adolescenziale. Parafraso qui quel che un grande e greve viticultore francese disse una volta a MacInerney che cercava di analizzare con piglio da enologo il nettare che stava bevendo: "you don't need to be a gynaecologist to fuck". Non bisogna lasciare che la propria vanità razionalizzante – o razionalità vanitante, fate vobis – ci impedisca di godere appieno della esperienza del piacere: farci inondare, lasciarci penetrare nell'anima e nel corpo da sottili rivoli palpitanti di vita.
Tornando castamente a noi, non posso mancare di segnalare il seicentesco produttore Gekkeikan che mi ha catturato per la gentilezza del suo personale giapponese. In degustazione un sakè non pastorizzato, di grande delicatezza e freschezza, che accompagnerei a pesce al vapore, carni bianche o formaggi freschi. Ho trovato invece repellenti i sakè frizzanti presentati da più di un produttore e stupidamente e insistentemente promossi per ragioni marchettare dai loro commerciali più giovani: si tratta di porcherie finalizzate al mercato americano o a imbesuire i nostri adolescenti. Un produttore serio e attento alla propria reputazione dovrebbe evitare di metterle in produzione, ma, si sa, pecunia non olet. Mi auguro che i giovani si sentano offesi nella loro capacità di discernimento e rifiutino di stordirsi con queste bibitine gassose, dolciastre, ruffiane e inebrianti. Bere poco, ma bere bene, semper. Il vino è storia e cultura solida sub specie liquida, non baumaniana.
Per fortuna esiste la France a difendere le liturgie e appunto un distributore francese ha allestito una postazione mettendo al fresco una serie di prodotti di Masumi che belle e competenti signore porgevano ai curiosi: tra i quattro vini offerti segnalo senza esitazione il Karakuchi Kiippon, di 15 gradi: uno straordinario sauvignon del riso, perfetto con le ostriche e superbo con un buon risotto di asparagi e carciofi. Indimenticabile per una nota di testa che ricorda molto i nostri formaggi grana con cui, peraltro, si accompagnerebbe benissimo in un aperitivo sincretista.
In crescendo segnalo altre due prelibatezze offerte dal distributore tedesco Ueno Gourmet: l'una è il Kameman Red Rice, ottenuto da riso rosso. Il risultato è un sakè rosé corposo come certi rosati del Salento o della Linguadoca. Un vino d'inizio pasto perfetto, anche accompagnato da olive, acciughe, pecorino o persino salumi. La seconda squisitezza, anzi – a mio umile e insindacabile giudizio – la massima espressione del sakè tra quelli presenti all'Umanitaria, era il Kirin Vintage 2013, dal bel colore ambrato. Morbido, abboccato, perfetto per l'invecchiamento e il foie gras o il cioccolato amaro.
Una piccola curiosità: i sakè più secchi o con note mandorlate e amaricanti si sposano sorprendentemente bene con il pesto servito sui crostini: ne vengono esaltati sia la freschezza del basilico sia una timida sfumatura citrina del sakè, in parallelo, sviluppando in bocca un'insolita percezione sensoriale doppia e ben distinguibile.
Non ho potuto evitare di fare una domanda che mi frulla in testa da un po', abitando io tra le risaie: se i giapponesi si sono messi a fare il whisky e quest'anno hanno ottenuto il miglior distillato al mondo superando gli Scoti, noi lombardi e piemontesi di marcita potremmo pensare di far fermentare i nostri risi con la stessa dedizione con cui otteniamo nebbioli, barbere, timorassi e cortesi? La risposta è sì per quanto riguarda la materia prima e il territorio e no per quanto riguarda la pelatura del riso, perché lì sta il segreto. Occorre la maestria che anche poche aziende in Giappone hanno – tant'è che lavorano per più produttori di sakè – e investimenti in macchinari che solo il Consorzio dei risi forse e pochi altri potrebbero permettersi. Io tuttavia continuo a voler sperare in un nostro sakè du terroir. Il problema del modesto consumo di sakè in Europa finora è stato soprattutto causato dalla mancanza di conoscenza del prodotto e dalla presenza di sakè di bassa qualità. Tuttavia anche il sushi non si conosceva e poi fu un boom di mercato. Non mi sorprenderei di un'evoluzione commerciale analoga del sakè, l'importante è che si moltiplichino iniziative come il festival finalizzate a far conoscere i migliori prodotti e a educare il consumatore.
È stata alla fine un'esperienza sensoriale esaltante. La scoperta di un mondo a me ignoto solo vagamente baluginato da scadenti prodotti da supermercato o da ristorante cinese camuffato da samurai. Ho preferito non pensare ad abbinamenti con la cucina giapponese, primo perché non la conosco molto bene e, secondo, perché la grande cucina tradizionale giapponese in Italia in sostanza non esiste o non merita particolare attenzione, Nobu compreso. C'è forse una sola eccezione, almeno a Milano e si deve alla sensibilità di un italiano. Quando lo proverò ve ne parlerò.
Il mio obiettivo era quello di interessarvi al vino di riso: se ci sono riuscito, brindo alla vostra.
[widgetkit id=27]