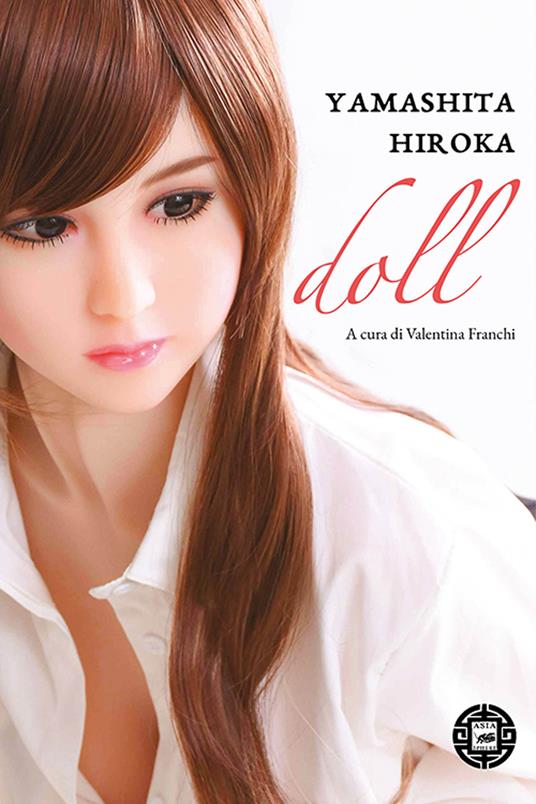Le nostre recensioni dal Far East Film Festival di Udine continuano con My Small Land, pellicola di debutto della giovanissima Kawawada Emma. Un toccante racconto di una vita divisa fra due culture, tre lingue, e un'infinità di scelte difficili.
Salya Çolak (Arashi Lina) ha diciassette anni ed è di origine curda. Vive nella prefettura di Saitama assieme al padre e ai fratelli minori da quando ne aveva cinque. A un primo sguardo la sua quotidianità appare quasi identica a quella delle sue coetanee giapponesi: le lezioni al liceo, le amiche, un lavoretto part-time in un convenience store. Ma c'è una parte di lei che è ancora legata alla cultura e alla vita in un paese che ormai non ricorda più, e che nasconde alle amiche e al suo collega Sōta (Okudara Daiken), per i quali lei è semplicemente "tedesca".
È solo nelle prime scene, infatti, che la vediamo indossare i vestiti tradizionali curdi, cantare e ballare per festeggiare un matrimonio. Dopo la cerimonia, Salya ritorna alla sua vita "giapponese", e cerca anzi di lavar via al più presto i segni lasciati dalla tinta rossa che viene applicata tradizionalmente sulle mani durante questo rito.

La sua quotidianità, però, viene sconvolta dalla decisione del governo giapponese di rifiutare la richiesta di asilo del padre, che tocca ovviamente anche lei e i suoi fratelli. Si ritrovano quindi a essere a tutti gli effetti dei cittadini illegali, senza permesso di soggiorno valido, e costretti a sottostare a diverse regole: vietato uscire dalla prefettura di residenza, vietato richiedere l'assicurazione sanitaria o gli aiuti statali, vietato anche lavorare. È in particolare quest'ultimo divieto che fa precipitare la famiglia nella disperazione, poiché senza lo stipendio che il padre Mazrum percepisce lavorando nei cantieri non hanno fonti di sostentamento.
Il divieto di lavorare, in realtà, colpisce anche Salya che, di nascosto dal padre, aveva iniziato a lavorare in un convenience store appena oltre il confine con l'area metropolitana di Tokyo per mettere da parte dei soldi per pagarsi gli studi. Salya, infatti, ha un sogno: diventare una maestra delle elementari e aiutare quei bambini che, come lei, arrivano da situazioni precarie o da altri paesi a integrarsi e ambientarsi nella loro nuova scuola. Per diventare insegnante, tuttavia, serve avere una laurea e una licenza speciale per l’insegnamento, e senza i risparmi del lavoro part-time è impossibile pensare di poter sostenere le spese universitarie.

La vita diventa sempre più precaria per Salya e i suoi due fratelli minori: Lilly, che non parla altra lingua se non il giapponese, e il timido Robin, che fa fatica a rapportarsi con i suoi coetanei a scuola e che si sente diverso, alieno. È proprio Salya a dover tenere tutto insieme, e a doversi dividere fra la scuola, la casa, e i mille favori che altri membri della comunità curda le chiedono vista la sua ottima conoscenza del giapponese.
Solo con Sōta, suo coetaneo conosciuto nel konbini, Salya ritorna finalmente aolescente. I due passeggiano, chiacchierano, vanno in giro in bici attraversando il confine fra la prefettura di Saitama e Tokyo. Vediamo nascere fra di loro un rapporto sempre più profondo, che diventa ancora più forte quando Salya rivela le sue vere origini al ragazzo – una tenera nota di "normalità" adolescenziale in una situazione quanto mai assurda e complicata.

Delicato racconto di un complicato coming of age, My Small Land porta sul grande schermo le storie e le sofferenze degli immigrati curdi in Giappone. Arrivati nella maggior parte dalla Turchia a partire dagli anni Novanta, si sono stabiliti principalmente nella cittadina di Warabi (prefettura di Saitama), affettuosamente chiamata "Warabistan". Secondo l'ultima statistica del 2021 in Giappone risiedono fra le 1500 e le 2000 persone di etnia curda.
Nonostante le domande aumentino ogni anno e vengano spesso presentate più volte, delle centinaia di richieste di asilo di cittadini turchi (quasi sempre rifugiati perché perseguitati in patria) nessuna è stata mai accettata. Come per la famiglia di Salya, il rifiuto dello status di rifugiato politico fa piombare queste persone in una sorta di limbo burocratico: non hanno un visto valido, quindi sono formalmente residenti illegali in Giappone. Hanno uno status di "residenza provvisoria" che permette loro di non essere rinchiusi nei centri di detenzione per gli immigrati illegali, ma che li sottopone a diverse limitazioni: non possono lavorare né uscire dalla loro prefettura di residenza, non hanno il diritto di accedere all'assistenza sanitaria o ai servizi di welfare – un problema esacerbato dalla situazione di emergenza sanitaria che tutto il mondo ha vissuto negli ultimi due anni (e che continua a vivere). Una singola visita dal dottore viene a costare una cifra astronomica, che queste persone ovviamente non possono permettersi in quanto disoccupati.
Molti rifugiati ricorrono quindi al lavoro illegale come operai o precipitano nella povertà. Essere scoperti a lavorare senza un permesso valido comporta il ritiro della residenza provvisoria e un periodo di detenzione indefinito. Di solito è solo grazie a uno sforzo comunitario che queste persone riescono a sopravvivere – e cioè con gli aiuti di amici e parenti che possono ancora lavorare, o che hanno un partner giapponese e quindi il permesso di soggiorno.
Kawawada è al suo primo lungometraggio. Nonostante questo, il film è capace di raccontare con delicatezza ma anche con estrema sincerità una storia che, per quanto opera di finzione, descrive la realtà di ormai tantissimi giovani di origine curda ma cresciuti in Giappone, che si sentono forse più giapponesi che altro. E che non vogliono lasciare quello che per loro è il loro paese, la loro casa, la loro vita.
Fonti: