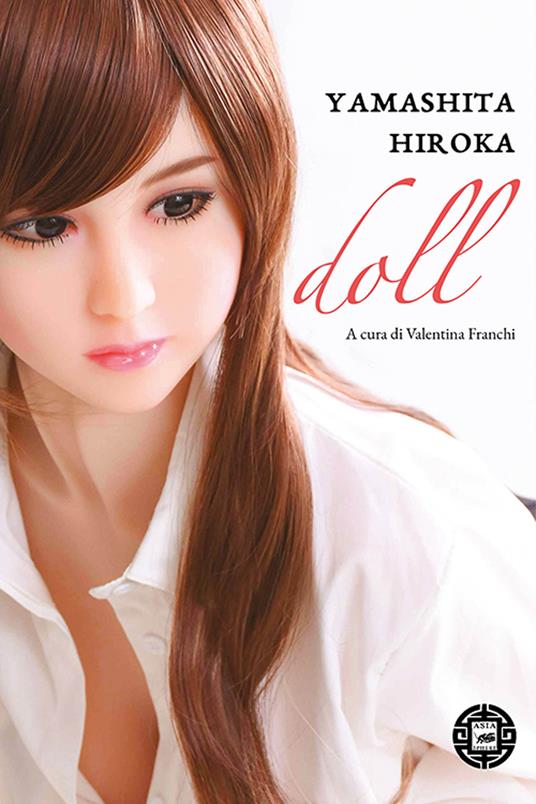Nel secondo ciclo di retrospettive dedicato ad artisti nipponici, il Far East Film Festival ripropone il grande classico Sumo Do, Sumo Don’t (Shiko funjattaシコふんじゃった), commedia di Suo Mayasuki del 1992 e uno dei primissimi film ad aver affrontato la disciplina del sumo con rispetto filologico.
Nonostante l’esordio nel pinku eiga con Abnormal Family:Older Brother’s Bride (Hentai kazoku: Aniki no yomesan変態家族兄貴の嫁さん), Suo Masayuki si è da subito distinto nel campo delle commedie brillanti originali, e questa pellicola in particolare è la prima a segnalarsi per lo stile di scrittura molto empatico e per l’umorismo spiccatamente “corporale” ed efficace.
Yamamoto Shuhei (interpretato da un giovanissimo Motoki Masahiro!) è un universitario scavezzacollo che ha già la strada spianata verso una carriera da salaryman in azienda, ma si scontra con un professore universitario che non gli permette di laurearsi a fronte di numerose assenze al suo corso. In cambio dei crediti necessari per la laurea, Shuhei è costretto ad unirsi al club universitario di sumo, in crisi e coordinato dallo stesso professore, dove figura un solo membro. Costruendo una squadra di veri e propri underdog, l’obiettivo è solo uno: vincere entro la fine dell’estate il torneo di sumo!
Riprendendo un canovaccio ben consolidato e popolare come quello dello spokon (un certo manga sportivo chiamato Slam Dunk stava già spopolando in quel periodo) e della rivincita dei reietti, la pellicola regala un’ora e quaranta di gag senza freni alternate a momenti più intimi e toccanti su ogni membro della squadra.

Come il regista stesso ha dichiarato in un’intervista anni dopo, il cuore pulsante della scrittura di un film per lui sono sempre le persone: nelle sue intenzioni ognuno dei personaggi ha una sua individualità e va sostenuta da una sceneggiatura e da manierismi che li rendano memorabili e soprattutto li facciano amare dallo spettatore. Tutti questi eroi sfigati, anche i più secondari, sono al centro di archi narrativi semplici ma efficaci, e dotati di importanti pay-off che rendono il loro percorso intrigante. Al centro il sumo, che come disciplina sportiva li aiuta in modi diversi a trovare uno scopo nella vita.
Il regista confeziona su di loro battute e gag ricorrenti che aiutano lo spettatore a definire nettamente le loro linee di desiderio e nel contempo concedono all’autore la libertà di “giocare” liberamente, intrecciandole per creare situazioni comiche sempre più varie e colorite.

Il sumo come disciplina sportiva, rispettando il canovaccio di queste storie, viene trattato in modo rispettoso e approfondito, ma è anche la base su cui costruire diverse situazioni interessanti, comiche o meno. Dall’ossessione quasi religiosa per il mawashi (l’indumento che indossano i lottatori) da parte del fanatico Aoki ai versi del poeta francese Jean Cocteau sulla disciplina, ripetuti a inizio e fine pellicola, è evidente come il regista e autore provi ammirazione per questo sport e tratti con amore ogni minimo dettaglio, lasciandosi anche la libertà di giocare con ogni sua idiosincrasia.
Il limite principale di questa pellicola è dato dalla prova del tempo: il film è uscito più di trent’anni fa ed è ovviamente cristallizzato negli usi e costumi della società giapponese dei primi anni ’90, e oggi fanno un po’ storcere il naso alcune battute legate alla sessualità eteronormativa e gli insulti che scadono facilmente nel sessismo e nell’omofobia, per quanto limitati a un solo personaggio antagonista.

La vera sorpresa però è stata il personaggio di Masako, la ragazza plus size che si unisce al club e che, sebbene sia all’inizio definita dalla sceneggiatura principalmente in relazione al genere, all’aspetto e alle abitudini alimentari compulsive, si trova al centro dell’arco narrativo più soddisfacente e interessante, che punta all’accettazione del sè e non a una possibile “normalizzazione”.
Tutti questi elementi della struttura rendono il film estremamente piacevole e gli conferiscono un deciso tocco empatico, per cui non mi stupisce che sia stato all’epoca insignito del Japan Academy Prize come Miglior Film. Contestualizzandolo nella retrospettiva proposta dal festival di Udine è anche il tassello fondamentale per comprendere l’origine e la struttura narrativa di Shall We Dance, la pellicola del 1996 più famosa di Mayasuki e presente alla kermesse udinese, il che rende la visione di Sumo Do, Sumo Don’t assolutamente necessaria.