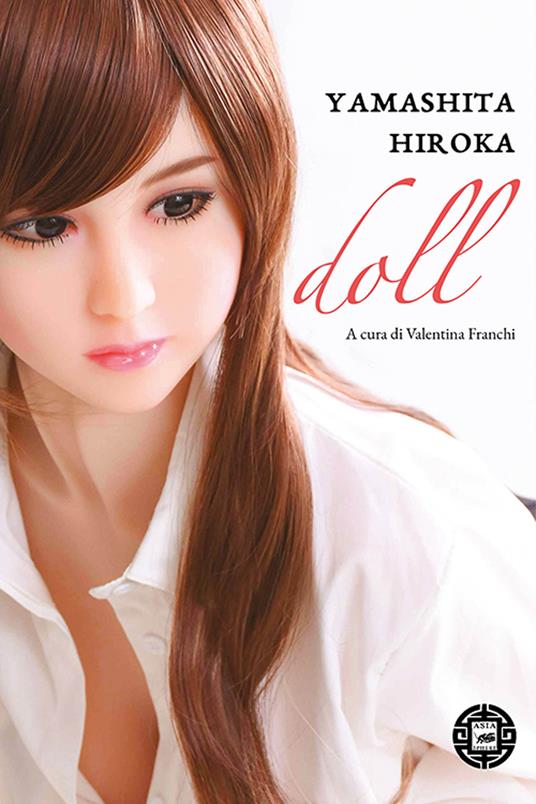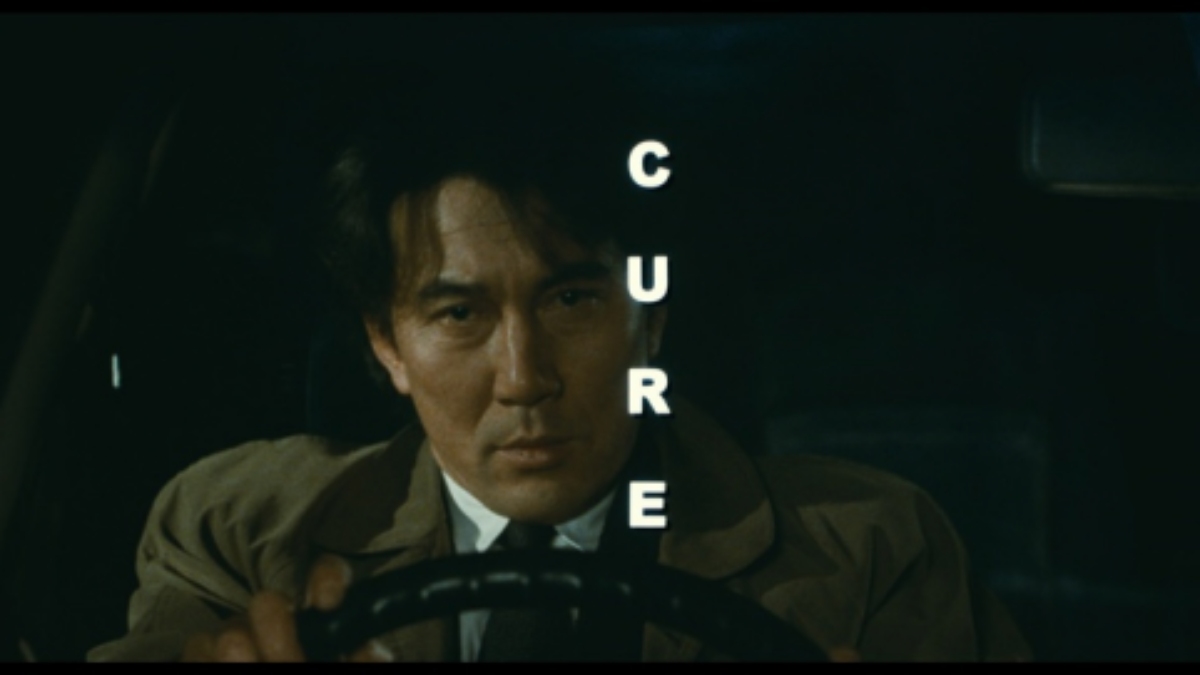Riepiloghiamo l'interessante dialogo fra Stefano Carrer (esperto di Giappone e Asia per il Sole-24Ore), Stefania Viti (giornalista ed esperta di food culture) e Pio D’Emilia (giornalista e scrittore, che da oltre trent’anni vive e lavora in Giappone) che si è tenuto in occasione di NipPop 2019: con Paola Scrolavezza come moderatrice hanno presentato il complesso mondo della cultura del cibo giapponese, dalle politiche culinarie fino al contatto con la cultura occidentale.
Partiamo introducendo il tema: cosa ne pensate della globalizzazione del sushi e della cultura culinaria giapponese?
Stefania Viti: Il sushi è stato la prima cosa con la quale il mondo ha identificato la cultura culinaria giapponese a partire dagli anni ’80, cioè dalla bolla economica. La forma del sushi rappresentava, anche a livello estetico, la quintessenza della cultura giapponese; aveva tutte le caratteristiche giuste, a differenza del ramen che è grasso, poco sofisticato. Si adattava benissimo all’immagine che il Giappone voleva dare di se stesso al mondo… Ci sono poi tanti motivi per i quali un cibo diventa famoso nell’immaginario globale. Un ruolo importante lo ha giocato l’onda dell’health food: si diceva che mangiare crudo, mangiare il sushi facesse bene, come se ci fossimo dimenticati che anche nella nostra cultura gastronomica si mangiano la carne e il pesce crudi. In realtà, come sostiene Pio D’Emilia nel suo saggio “Sua maestà il sushi”, noi siamo stati gli ultimi a scoprire il sushi e la cultura gastronomica giapponese. Abbiamo fatto tante scoperte, ma per quel che riguarda l’universo culinario dell’altro siamo rimasti un po’ indietro. Ma meno male che finalmente li scopriamo anche noi! C’è da dire che scopriamo la cultura giapponese perché, come dice Pio, si è creato una sorta di binomio italo-giapponese, sono due cucine che si intendono, che parlano molto bene dal punto di vista del gusto, della tecnica e dell’estetica.

Stefania diceva che negli anni ‘80 c’è stato un boom, che ha attraversato una serie di paesi fino ad arrivare anche in Italia. Quanto il Giappone ha promosso questo boom, e quanto è stato un movimento spontaneo da fuori?
Pio D’Emilia: Attualmente il Giappone ha 7 istituti di cultura. Noi 83. La Cina 500. Quindi che il governo giapponese abbia interesse a promuovere la propria cultura è pura letteratura. Non è così. La promozione avviene invece sua sponte. La promozione è nata perché, come diceva Stefania citandomi, c’è una fatale attrazione tra la cucina giapponese e quella italiana, due cucine con qualche punto in comune: il rispetto assoluto degli ingredienti, il fatto di essere un po’ gastrofondamentaliste. Quindi da questo punto di vista siamo facilitati. Poi, purtroppo, noi che avremmo dovuto essere i primi ad aprire la nostra cultura alla cucina giapponese siamo stati di fatto gli ultimi. Non solo, ma stiamo soffrendo di questa moda velocizzata, di questa moda fast-forward a prezzi molto alti.
Un esempio di conservatorismo culinario giapponese?
Stefania Viti: Nel mio ultimo libro, dedicato al sake, cito alcuni locali che si occupano di cocktail. Il primo che apre questa sezione è un mixologist giapponese, un genio della mixology, uno che ha vinto un premio in Sud Africa: Michito Kaneto. Vive a Nara, la culla del sake. Volevo intervistarlo e ho chiesto i suoi contatti ad alcune cantine in zona. Non me l’hanno dato! Mi hanno detto “Quello che fa i cocktail non ha nulla a che vedere con noi, che facciamo il sake”. Poi invece qualche tempo dopo – sono dovuti passare quattro anni – si sono resi conto che il consumo interno calava e dovevano spostarsi verso l’esterno, e ho ottenuto il contatto. Però c’è sempre una reticenza, anche da parte dei giapponesi, a cambiare.
Che ne pensate del problema della “falsa cucina giapponese” e degli All you can eat?

Pio d’Emilia: Pensate che a Milano ci sono oltre 400 ristoranti “giapponesi” ma in realtà solo 18 sono davvero giapponesi. E con “giapponese” intendo che ci sia un cuoco giapponese (itamae) con tutto quello che comporta: non significa semplicemente fare a pezzi un pesce, ma significa andarlo a comprare, saperlo distinguere, saperlo tagliare, saperlo conservare, saper preparare il riso. Esistono itamae che passano quattro anni a preparare il riso prima di mettere le mani sul pesce. Ecco, il fatto che tutto questo sia, come dire, superato in curva dagli chef cinesi, vietnamiti, indonesiani… gente che ha avuto al massimo un paio di mesi di esperienza da assistente chef! Questo non significa che non dovete andare all’All you can eat, però dovete sapere che non è la stessa cosa.
È sempre questo il caso per quanto riguarda cucine di un paese replicate all’estero? Ad esempio, quella italiana in Giappone e viceversa?
Pio d’Emilia: Tokyo è il posto dove si mangiano le migliori cucine indiana, pakistana… Si dice che essere bravi nelle cucine altrui è tipico dei paesi in cui si mangia male; ma questo non è affatto il caso giapponese. C’è una grande capacità di copiare, talvolta anche eticamente, la cucina altrui. Io non ho mai mangiato cucina italiana all’estero meglio che in Giappone.
Stefania Viti: Tokyo è inoltre la città col maggior numero di stelle Michelin di tutto il mondo. Questo per confermare quello che diceva Pio, cioè che Tokyo è al top di tutte le cucine. Però forse è il caso di raccontare anche quello che succede dal punto di vista economico.
E chi meglio di Stefano?
Stefano Carrer: In Cina, pochi giorni fa, c’è stato giusto un grande convegno sull’accordo di scambio che è entrato in vigore il primo febbraio. Tra i simboli di questo processo è stato additato il fatto che il vino italiano ora entra in Giappone senza più dazi e il sake giapponese entra in Unione Europea, e in Italia, senza dazi. È un esempio di come il cibo abbia un ruolo fondamentale non solo nelle dinamiche di globalizzazione a livello di business, ma come abbia avuto un ruolo storico importante nell’approfondire la conoscenza reciproca tra mondo giapponese e mondo italiano. Da questo punto di vista, Abe ha dovuto antagonizzare la lobby agricola locale, assolutamente contraria a fare accordi di libero scambio. Però è chiaro che nel momento in cui l’agricoltura giapponese si riduce sempre di più al liminale, un paese come il Giappone ha bisogno di garantirsi spazi di mercato con il suo export di prodotti manifatturieri, e diviene molto più importante garantirsi questo che non tutelare con un protezionismo di vecchio stampo il settore agricolo. Tra l’altro il negoziatore capo di questo accordo, un italiano, ha sottolineato come uno degli scogli più difficili che ha imposto questa maratona di giorni e giorni sia stato quello dei formaggi.
Non si può dimenticare l’importanza dell’autopromozione, in questo. Che cosa ne pensate?

Stefano Carrer: Negli ultimi anni il governo giapponese ha capito che doveva avvicinarsi un po’ al modello italiano, nel senso di manifestare e valorizzare il proprio soft power a livello internazionale attraverso attività come il washoku, patrimonio immateriale dell’umanità per l’Unesco. C’è stata addirittura una corsa delle diverse prefetture giapponesi a semi-inventare prodotti tipici, per cui adesso se andate in Giappone ogni prefettura ha il proprio cibo particolare, il che a livello turistico è una strategia vincente.
Stefania Viti: Quando parlavamo di globalizzazione, io credo che per quanto riguarda la cultura giapponese siamo di fronte veramente a un periodo storico di apertura quasi senza precedenti, a livello non solo di apertura culturale, ma anche di quantità di persone che transitano nel paese.
Tuttavia, questa autopromozione del Giappone sembra concentrarsi di più sul soft power che sui grandi nomi…
Pio d’Emilia: Effettivamente il soft power giapponese è molto soft, molto superficiale. Il Giappone è un paese che negli ultimi trent’anni è rimasto fermo dal punto di vista industriale ed economico. Da quant’è che non sentiamo un brand come Sony entrare nelle nostre case? Oggi quello che entra è il manga, l’anime.
Stefano Carrer: Più che le grandi marche, è il turismo ad aver avuto il maggior successo. Mentre in passato il Giappone aveva una bilancia domestica assolutamente negativa, da tre anni è diventato una grande attrazione turistica, quindi sono di più gli stranieri che vanno a visitare il Giappone che non i giapponesi che vanno a fare vacanze all’estero.
Stefania Viti: Il Giappone entra ancora nell’immaginario collettivo locale come potenza tecnologica – si pensi alla Toyota – ma dopo 20, 30 anni di leadership il sistema è superato, anche a causa del conservatorismo nipponico.
Pio d’Emilia: Le policy del Cool Japan – una settantina di progetti sovvenzionati dallo stato giapponese per promuoversi all’estero – sono da considerare più come dei palliativi. La prima cosa che il Giappone dovrebbe fare è migliorare la propria immagine sociale. Il paese è ancora molto arretrato da un punto di vista sociale, soprattutto nei confronti delle donne.
Stefania Viti: Questa è proprio l’idea che ho anch’io di queste politiche di promozione che di fatto puntano ai veri problemi economici, politici e sociali. Chi frequenta il Giappone, chi lo studia, credo che percepisca questi limiti, anche al di là del food.

Qualche pensiero sulla attuale condizione socio-economica delle donne in Giappone?
Stefano Carrer: “Womenomics”, termine coniato da Kathy Matsui, analista di Goldman Sachs in Giappone, indica la promozione della donna nel mondo del lavoro. In anni recenti è effettivamente aumentato il numero di donne che lavorano. Il motivo è ovvio: il governo conservatore si è scoperto un po’ femminista in questo senso perché, a fronte di gravi carenze di disponibilità di manodopera sul mercato del lavoro, ogni donna in più che lavora, così come ogni anziano in più che lavora, è un immigrato in meno.
In che direzione pensate che si muoverà il Giappone d’ora in avanti?
Pio d’Emilia: Ora si deve capire se il Giappone voglia rilanciare se stesso come potenza industriale oppure, cosa che secondo me è molto più credibile, rassegnarsi come l’Italia a essere un paese di servizi, e uniformarsi e accettare anche politicamente il nuovo ruolo. Negli anni ’80 era simbolo di qualità a basso prezzo, oggi è simbolo di “… Vale la pena davvero?”
Stefano Carrer: A mio parere, in futuro cambierà l’esperienza immediata della visita in Giappone. Ci sono programmi per le Olimpiadi dell’anno prossimo che prevedono di mettere sempre più cartelli e segnali in inglese, ma anche in coreano e cinese. Mentre in passato l’esperienza era quella di andare all’izakaya (il pub alla giapponese) ed essere sconvolti perché anche dopo anni di studio del giapponese non si riusciva comunque a decifrare i menù, probabilmente la maggior parte delle izakaya ora avrà un menù in altre lingue. E questo è un progresso per la facilitazione dei flussi turistici, anche se magari un po’ meno efficace nel dare l’impressione di un Giappone come mondo a parte, una parte fondamentale dell’esperienza della visita al paese nel passato. Quindi lo vedremo anche un po’ più omologato.
È molto interessante vedere come il Giappone si aprirà nei confronti del resto del mondo. Ma come influiranno i nuovi accordi sulle abitudini del consumatore italiano? Ad esempio, potrebbe, in futuro, il nostro vino essere sostituito con il sake?
Stefania Viti: Da questo punto di vista, nell’introduzione dei prodotti giapponesi in Italia si assiste un vuoto, un vuoto pieno di fraintendimenti e di mancanza di cultura. Alla base del grande successo del sushi c’è un grande equivoco: alla semplicità della forma si è creduto che corrispondesse una ricetta altrettanto semplice, quando invece è una delle ricette più complesse dell’intero universo culinario. È semplice dal punto di vista degli ingredienti, è difficilissimo invece dal punto di vista della preparazione. Il cambiamento da vino a sake potrebbe avvenire, ma alla velocità di globalizzazione della nostra esperienza culinaria bisogna opporre una uguale ondata di informazione riguardo a quello che si mangia.